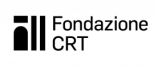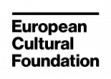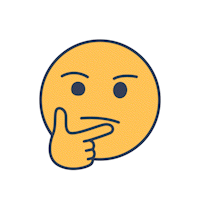My First Film di Zia Anger | L’aborto come creazione
Year
Runtime
Director
Cinematographer
Production Designer
Country
Format
Genre
Subgenre
In Essere e Tempo, Martin Heidegger parla dell’errore non come l’opposto della verità, ma come il suo necessario cammino. È nell’errore, sostiene il filosofo tedesco, che si nasconde la possibilità stessa della scoperta; nel dosare sapientemente svelamento e occultamento. L’artista e regista Zia Anger ha fatto di questa dialettica tra trasparenza e occultamento il suo manifesto. A settembre, MUBI ha presentato in esclusiva My First Film, il suo esordio alla regia.
L’opera semi autobiografica, che ha già fatto discutere al CPH:DOX (Copenhagen International Documentary Festival), si distingue soprattutto per due aspetti: la sensibilità e lo stile narrativo. Anger, artista dedita principalmente al mezzo audiovisivo, ha costruito la sua carriera spaziando dai videoclip alle performance multimediali. È proprio da una di queste, realizzata nel 2019 e anch’essa intitolata My First Film, che nasce il materiale per questo debutto cinematografico.
- Questa (non) è una storia vera
- Maternità artistica e autodeterminazione
- L’arte del fallimento
- Abortire è una presa di coscienza
- Un’opera metacinematografica
- La solitudine dell’insuccesso
Questa (non) è una storia vera
Quasi 15 anni dopo i suoi primi tentativi registici, vediamo Vita (Odessa Young), alter ego di Anger, ripercorrere il travagliato percorso di realizzazione del suo primo film. La storia originale, Always All Ways, Anne Marie, raccontava di una giovane donna incinta che decide di abbandonare la propria casa alla ricerca della madre. Un progetto ambizioso che, nonostante la presenza dell’amica Dina (Devon Ross), si trasforma in un vortice di caos e di eventi quasi fatali, specchio dell’inesperienza e dell’entusiasmo della giovane artista.
Con il procedere della produzione, rocambolesca e improvvisata, emergono interrogativi sempre più profondi: sul senso stesso di narrare una storia, sulle modalità del racconto e su quanto di personale un autore lasci nelle sue opere. Anger, attraverso Vita, gioca sulla sovrapposizione tra la sua storia personale e quella della protagonista. Alternativamente, dichiara che la storia a cui si sta assistendo è ora vera, ora falsa. Il tentativo di un “primo film”, progetto che la regista ha infine abbandonato, è stato un fallimento sotto ogni punto di vista: rifiutato dai festival, costato diversi cambi di troupe e ignorato dalla critica.
Anger intende riscattare quel fallimento, ricordando le parole di Samuel Beckett: “Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio.” Un mantra che diventa metodo, estetica, rivelazione. Uomini e artisti raccontano la propria storia attraverso i successi, ma la scrivono attraverso i fallimenti.
Maternità artistica e autodeterminazione
My First Film trascende il semplice memoir autobiografico attraverso un dialogo costante tra passato e presente. Anger intreccia magistralmente la metafora della creazione artistica in stile 8½ (1963) di Federico Fellini con quella della maternità, sviluppando un discorso femminista e postmoderno. E proprio i temi dell’aborto e della gravidanza emergono prima dal sottotesto cinematografico e poi occupano lo spazio simbolico principale. Questi temi vengono trattati con uno sguardo affettuoso, umano e profondo, evitando un approccio sensazionalistico.
La regista suggerisce che ciascuno dovrebbe poter partorire ciò che desidera – che sia un figlio, un’opera d’arte o persino il fallimento stesso – rivendicando la propria agentività e, tra le righe, quello che Adrienne Rich avrebbe definito “l’io perduto”. È una decostruzione della prospettiva comune che vede nella maternità la vocazione femminile per eccellenza. Vita vuole affermare con forza che anche il fermarsi o il non fare possono essere scelte possibili e di pari valore. Come le dice la dottoressa (Sarah Michelson) verso la fine del film: “You know, all you need is a body to create. But what you create is up to you.” (“Sai, tutto ciò che ti serve per creare è un corpo. Ma ciò che che credi dipende da te.”)
L’arte del fallimento
Come in Synecdoche, New York (2008) di Charlie Kaufman (da cui riprende anche diverse intuizioni ricorsive), il fallimento creativo diventa il fulcro di una narrazione più ampia sull’identità artistica e personale. Una ristrutturazione necessaria della propria identità quando i progetti non vanno come previsto, specie quelli d’esordio, investiti di un’aura sacrale da venuta al mondo. “Questo film sono io”, ripete spesso Vita alla sua troupe, dedita alla produzione come in una sorta di missione per l’affermazione personale. Missione che vive con l’intensità emotiva cruciale di un passaggio liminale di stato.
Condividere anche l’errore, dargli dignità e luce è un modo per cercare una connessione e per non sentirsi soli. “Perché sono l’unica a cui succedono queste cose?”, si chiede spesso la protagonista nel corso del film. “Succedono a tutti, è solo che normalmente non ne parliamo”, le viene risposto. Una prospettiva che a prima vista richiama le riflessioni esistenziali de La nausea di Jean-Paul Sartre o de La caduta di Albert Camus. Tuttavia, qui il fallimento si trasforma contemporaneamente in un mezzo di auto-conoscenza e rinascita, così come di connessione e prossimità.
Abortire è una presa di coscienza
Anche il non-nato, il non-detto, rappresentano una scelta e una storia. Non una colpa, ma un atto di coraggio e autodeterminazione. Il film lo ribadisce a più riprese nel finale, poetico e di rara potenza, durante la lunga sequenza mimata di un aborto.
Un film sul riscatto attraverso l’accettazione, ma un’opera cinematografica che interroga la sua stessa natura. Dal perché si raccontano storie, perché sono importanti per gli umani, fino al domandarsi se esistono storie che non raccontino in fondo tutto dell’autore. Vita confida di aver letto che i registi passano la vita a ripetere sempre lo stesso film. La stessa idea sottesa che cercano di esprimere nel modo migliore possibile. E allora, forse, non c’è differenza tra un film e una confessione. L’importante è la sincerità, la presenza.
Nel tumulto della creazione, delle aspettative e del progettare, Vita è disconnessa. Disconnessa dalle relazioni personali, da se stessa e dagli amici che ha coinvolto nel progetto, tanto da mostrarsi spesso ostile o persino ad arrivare a manipolarli per i suoi fini. Eppure, proprio quando tutti l’abbandonano a causa del suo comportamento, viene richiamata al qui e ora. Mentre si ritrova a improvvisare una sceneggiatura con il padre e l’ultima amica rimasta, perde il controllo sugli attori. Ma arriva l’epifania: “It’s just for a moment. I stopped caring. Because it was so beautiful. Just to be making something with people.” (“È solo per un momento. Ho smesso di preoccuparmi. Perché era così bello. Solo il fatto di creare qualcosa con le persone.”)
Dalla connessione con gli altri, dalla vicinanza umana e dalla comprensione, riprende l’atto creativo del raccontare storie.
Un’opera metacinematografica
È proprio attraverso la struttura metacinematografica che si entra nell’intimità dei pensieri di Vita. Si crea così un consapevole cortocircuito tra diversi livelli di narrazione e percezioni della realtà. Inserti con diversi stili, pellicole, rotture della quarta parete e salti temporali. Ad esempio, la regista comunica spesso con il pubblico (e non solo) attraverso le prime righe di una pagina di Word. Oppure tramite un costante voiceover che analizza e reinterpreta il girato con la consapevolezza di Vita (o di Anger) del presente, ricordando spesso Sans Soleil (1983) di Chris Marker.
Questa dinamica crea uno scambio complesso tra la sua coscienza adulta attuale e le impressioni della sua sé venticinquenne del passato. Come se Anger volesse raccontarsi di nuovo, da un punto di vista diverso e più distaccato. Si sviluppa così una costante dialettica che apre una porta su un’intimità sincera e spesso sorprendente.
La spontaneità e il carisma di Odessa Young contribuiscono a creare un’opera visivamente disorientante. Al contempo, rimane coerente con l’impeto creativo e la turbolenza interiore della giovane regista protagonista. Assistere al film significa assistere a una coscienza viva che ricorda e rimugina, in cerca di liberazione. Attraverso questa complessa stratificazione di significati, My First Film riesce a riflettere contemporaneamente sul potere e la libertà, così come sulla gioia e il dolore che accompagnano ogni atto creativo e la condizione umana.
La solitudine dell’insuccesso
Nel cuore della narrazione, Vita e Zia Anger, ormai temporaneamente sovrapposte, confessano che non c’è una ragione per la scelta di realizzare un film di questo tipo. “I don’t know how to talk about these things. Or I don’t trust the rules of cinema to do them justice” (“Non so come parlare di queste cose. O non mi fido delle regole del cinema per rendere loro giustizia.”) Ed ecco che le regole vengono sovvertite e riscritte non per iconoclastica, ma con un dosato senso del necessario.
Non sapendo come parlare del fallimento, Zia Anger lo racconta in tutto il suo ventaglio di sfaccettature: da quello personale a quello collettivo; da quello sentimentale a quello artistico. È proprio per questo motivo che il suo approccio è stato definito “un contributo eccezionale alla trasparenza radicale”. Non sapendo quale sia il mezzo giusto, Anger li usa tutti, a più piani e con eleganza. Non si tratta della coscienza arresa di un Sisifo, ma dell’amore incondizionato di una madre nei confronti di qualsiasi espressione generata.
Accettare la propria creazione, qualunque essa sia, anche la non creazione stessa, è un’affermazione identitaria. Dare vita a qualcosa significa generare una nuova forma di sé. E in questo, come afferma Vita: “Every time you find a new version of the truth.” (“Ogni volta trovi si trova una nuova versione della verità.”)
Tag
Buy a ☕ for Hypercritic