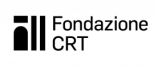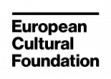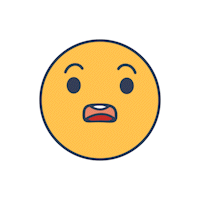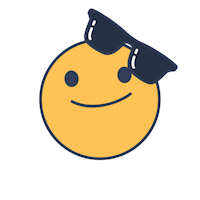Alien | La paura è negli occhi di chi guarda
Year
Runtime
Director
Main Cast
Cinematographer
Production Designer
Music by
Format
“Nello spazio nessuno può sentirti gridare”. Così recita la frase di lancio di questa pietra miliare della fantascienza e dell’horror, riassumendo alla perfezione lo stato di terrore e isolamento che permea il film di Ridley Scott. Con la sua narrazione diretta ma leggibile a più livelli, Alien offre a chi guarda molteplici interpretazioni, oltre a un biglietto per una casa degli orrori in mezzo allo spazio profondo.
Nelle profondità dell’universo, l’astronave da carico Nostromo riceve quella che sembra essere una richiesta di aiuto da un pianeta sconosciuto. L’equipaggio (cinque uomini, due donne e un gatto) segue il segnale fino a una navicella aliena abbandonata, ma quando un misterioso parassita si attacca a uno degli astronauti, l’incubo si scatena: un alieno indistruttibile con acido al posto del sangue si è appena imbarcato sulla nave, e presto inizia a uccidere l’equipaggio uno ad uno.
Un B-movie di serie A
Non voglio renderlo un film più importante di così. Voglio che sia un thriller diretto, coinvolgente e senza pretese, come Psycho o Rosemary’s Baby. Ma voglio che sembri, e farò in modo che sembri, 2001: Odissea nello spazio.
Il regista Ridley Scott, in un’intervista dal libro Dietro le quinte di Alien di J. W. Rinzler
Nonostante gli 11 milioni di dollari di budget da produzione di prima fascia, Alien è, in fondo, un B-movie. O almeno, questa era l’intenzione degli sceneggiatori Ronald Shusett e Dan O’Bannon. Quest’ultimo aveva appena finito di lavorare al film d’esordio di John Carpenter Dark Star (1974) – un cult della fantascienza satirica, prodotto a basso costo – ed entrambi intendevano seguirne le orme. La loro sceneggiatura assimila e rielabora la lunga tradizione dei film di fantascienza orrorifica anni ’50, prendendo allo stesso tempo spunti anche dalla letteratura di genere.
La serie di omicidi uno ad uno per mano di un assassino invisibile, e il progressivo isolamento che ne deriva, rispecchiano quelli di Dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Il tocco di H. P. Lovecraft, padre del sottogenere del cosmic horror, aleggia su tutto. Anche il più antico mostro della letteratura inglese fa la sua parte: il sangue acido dell’alieno in origine apparteneva a Grendel, del poema epico Beowulf.
Il terrore vicino allo spettatore
Quel che ha reso Alien un film ‘di serie A’ non è però solo il grande investimento, ma la serietà con cui venne trattata l’impresa di fare paura (più che la materia narrativa in sé). Nell’horror, Ridley Scott vedeva una sfida: spingere il terrore il più vicino possibile al pubblico, come già avevano fatto gli instant classic L’Esorcista (1972) e Non aprite quella porta (1974). Nella fantascienza, vedeva un’opportunità, quella di mettere in mostra tutta la destrezza visiva che aveva imparato a padroneggiare nei suoi anni da regista pubblicitario. E avrebbe continuato a seguire questa strada con il suo film successivo, un altro classico di fantascienza: Blade Runner (1982).
Questo patchwork si rivelò un successo. Alien diede inevitabilmente il via a un filone (il rifacimento di La Cosa nel 1982 da parte di Carpenter è un’operazione molto simile), e le sue intuizioni e innovazioni diedero nuova linfa vitale a tutti i generi coinvolti.
Classe operaia dallo spazio profondo
Una prima novità si trova nei personaggi. Nelle stesure successive (non accreditate) della sceneggiatura, Walter Hill e David Giler riscrissero gli astronauti come ‘camionisti nello spazio’, “non esploratori, ma operai” (come ha notato il critico Rogert Ebert), con i quali il pubblico potesse identificarsi più facilmente. Si aggiunse presto un risvolto di critica sociale.
Ispirandosi al sottogenere corporate thriller degli anni ’70 (Giler coscrisse il film di cospirazione Perché un assassinio del 1974 di Alan J. Pakula), i due aggiunsero alla storia già ricca di suspence un elemento di paranoia. Nella loro lotta per la sopravvivenza, gli astronauti, ora divisi per classe, devono tenere d’occhio anche l’onnipotente compagnia che li ha assunti. Le uniche persone che potrebbero sentirli gridare non lo faranno, e anche potessero non ci si può fidare.
Mentre l’equipaggio si assottiglia e si scatena una guerra di nervi, diventa sempre più difficile per il pubblico capire chi è chi. E soprattutto, chi ne uscirà vivo.
La ragazza che sapeva combattere
Il risultato, all’epoca, fu piuttosto sorprendente. La dinamica eroe/donzella in difficoltà viene capovolta: gli uomini diventano inetti, e l’unica capace di prendere in mano la situazione e combattere il mostro è una ragazza. Interpretata dall’esordiente Sigourney Weaver, la protagonista femminile (un’altra idea di Giler e Hill) si allontana dal topos della final girl che dilagava negli anni ’70 (la Sally Hardesty di Non aprite quella porta era apparsa nel 1974, la Laurie Strode di Halloween nel 1978).
L’Ellen Ripley di Alien non si limita a sopravvivere, ma dimostra resilienza, coraggio, autocontrollo e leadership. Qualità che in quel periodo, sul grande schermo, secondo la tradizione e lo stereotipo appartenevano quasi esclusivamente agli uomini. Ripley si affermava non solo nel film, ma nell’intero mondo del thriller e dei film azione.
Dopo di lei, è stato più facile per le altre eroine emergere in opere di tensione, la maggior parte delle quali ancora si rivolge a un pubblico prevalentemente maschile tramite eroi maschili (Sarah Connor della saga Terminator deve molto a Ellen Ripley). Data la scommessa vincente, Weaver sarebbe tornata nei tre sequel del film: Aliens (1986) di James Cameron , Alien 3 (1992) di David Fincher e Alien Resurrection (1997) di Jean-Pierre Jeunet. Ma questa è un’altra storia.
Il design sotto la pelle
Altro motivo del successo del film è l’alieno del titolo e il suo peculiare concepimento. La trama ruota attorno al suo ciclo di vita omicida, che trasforma sessualità, gravidanza e nascita in qualcosa di mostruoso. Con la sua violenza e il suo desiderio di riprodursi, l’alieno porta gli impulsi umani alle loro estreme conseguenze.
Lo scopo è chiaro: colpire le parti più sensibili di chi guarda, rendere perverso ciò che trova familiare e rassicurante finché non lo teme, ritorcergli contro i suoi stessi istinti fisiologici. È la quintessenza del body horror. Il sottogenere si stava sviluppando sotto l’ala di David Cronenberg con film come Il demone sotto la pelle (1975) e Brood – La covata malefica (1979), e Alien ne diventò presto un punto di riferimento.
Ma a differenza di Cronenberg, Scott non poteva permettersi di mostrare questi orrori di petto. Se voleva raggiungere un pubblico di massa, doveva schivare i contenuti potenzialmente repellenti che si annidavano nella sceneggiatura. Doveva fare della necessità di essere sottile una virtù. Doveva affidarsi a un correlativo oggettivo, che trovò nel design bio-meccanico dell’anatomia e del pianeta natale dell’alieno.
La mente dietro questo immaginario è il pittore svizzero H. R. Giger (che O’Bannon aveva conosciuto durante la pre-produzione, poi interrotta, del Dune di Jodorowsky). L’artista aveva presto imparato la lezione di Hieronymus Bosch, Antoni Gaudí, Alfred Kubin e Francis Bacon. Riversando sulla tela le sue visioni più intime e tormentate, Giger raggiunse un’estetica neo-surrealista, vivida e del tutto personale: la soluzione perfetta per l’impresa di portare avanti le allusioni Eros-Thanatos della storia. Il design di Giger si insinuò immediatamente sotto la pelle dello spettatore e nella memoria collettiva, e da allora non se ne è più uscito.
Un incubo dentro un sogno
È curioso che nella prima stesura della sceneggiatura da parte di O’Bannon, l’alieno fosse del tutto astratto. Il mostro fungeva da incarnazione dell’Es, il lato istintivo della personalità che si cela sotto quello razionale. Nonostante le tante riscritture e il design molto fisico di Giger, la metafora è ancora valida.
L’alieno incarna la paura del buio e dell’ignoto. L’equipaggio non riesce a pensare a un modo per uccidere l’indistruttibile creatura perché la ragione è inutile contro un mostro che va al di là di essa. La sola vista dell’alieno li paralizza, ma dovranno sopportarla, dovranno trovarsi di fronte al terrore fatto a persona, come in un incubo.
La natura onirica della trama sarebbe stata ancora più chiara con la citazione che inizialmente doveva aprire il film:
Viviamo come sogniamo, soli.
Tratto da Cuore di Tenebra di Joseph Conrad
Dopo tutto, il film inizia e finisce con i personaggi che si svegliano e vanno in iper-sonno. L’intera vicenda è una parentesi da incubo all’interno di un sogno nello spazio profondo?
“Tutto quello che vediamo, quel che sembriamo non è che un sogno dentro un sogno” si potrebbe rispondere, citando la poesia di Edgar Allan Poe sulla vanità di tutte le cose. In questo senso, il fatto che “nello spazio nessuno può sentirti gridare” non è solo una questione di terrore e isolamento, ma di come il dolore dei personaggi non abbia significato in confronto all’immensità dell’universo. È un tema ricorrente del cosmic horror, e dà al film un che di metafisico.
La paura è negli occhi di chi guarda
Alien evoca un cocktail letale di claustrofobia e agorafobia. Per quanto minuscola in confronto allo spazio, l’astronave Nostromo è di dimensioni gigantesche e soffocanti, con tutti i suoi numerosi, strettissimi ponti. In questo labirinto perennemente oscuro, l’alieno potrebbe nascondersi ovunque. E l’occhio della macchina da presa aumenta il terrore da “febbre del chiuso”.
Le inquadrature dal basso, con soffitti in piena vista, abbondano, di modo da non lasciare a chi guarda alcun sollievo visivo. Nel passaggio da una scena a un’altra, la macchina da presa si concentra su interni deserti, facendo sembrare la Nostromo una nave fantasma alla deriva tra le galassie. Immagini alla Star Trek, in cui gli astronauti guardano le stelle dal finestrone del ponte di comando, sono assenti. L’universo non è una distanza che l’equipaggio può semplicemente attraversare, ma una prigione infinita, fuori e intorno all’astronave (già di per sé una gabbia). Lasciare la nave infestata equivale a perdersi nello spazio.
Un incubo a doppio senso
Non c’è via di fuga dalla minaccia aliena. Eppure, nonostante tutto, l’alieno stesso si vede raramente. Come in Psycho (1960) di Hitchcock e Lo squalo di Spielberg (1975), la figura intera del killer viene riservata per il gran finale. Nel frattempo, tocca al pubblico completare ciò che lo schermo lascia solo intendere. La creatura cambia nell’immaginazione di chi guarda, aumentando al massimo la paura. E il montaggio di Terry Rawlings ci marcia sopra, montando le scene degli attacchi alieni a un ritmo forsennato, con effetti quasi subliminali.
Alien è un incubo a doppio senso, in cui il grande schermo fa da specchio deformante. Scott sapeva che, in fin dei conti, ciò che poteva spaventare di più il pubblico era il pubblico stesso. Il film non avrebbe mai raggiunto il successo mondiale se tutti gli artisti che vi hanno lavorato – con le loro diverse esperienze e competenze – non lo avessero tenuto presente. Alla fine, Alien è il risultato di un lavoro di squadra, guidata da una semplice verità. L’adagio dice: “La bellezza è negli occhi di chi guarda”. Lo stesso vale per la paura.
Tag
Buy a ☕ for Hypercritic